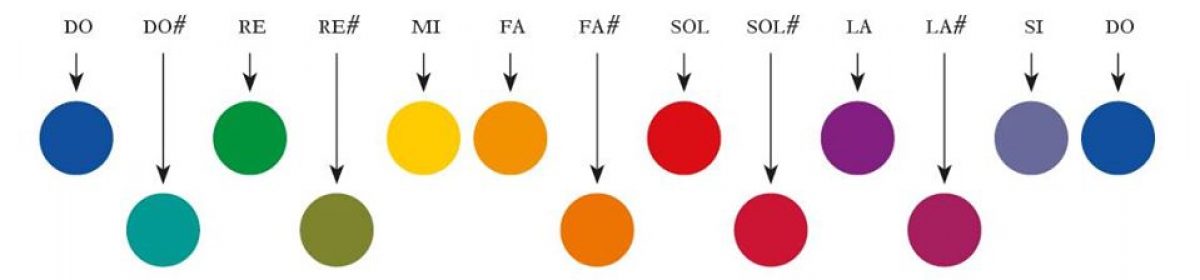Evento irripetibile, l’inagurazione del nuovo Teatro dell’Opera di Firenze, una costruzione che si attendeva da oltre cinquant’anni, chiude egregiamente l’anno di celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità d’Italia. Per una sera ci si lascia alle spalle sia le polemiche relative ai costi esosi del progetto, sia la causa tuttora in corso che sembrò a un certo punto minare la conclusione dei lavori.
Il gioiellino architettonico ideato dallo studio romano A.B.D.R., come forse non se n’erano ancora visti in Italia (anche considerando che l’auditorium di Ravello è ancora chiuso), dalla platea risuona di un’ottima acustica, morbida e calda, merito certo del legno di pero di cui è foderata la sala principale (l’unica già portata a termine). Tuttavia i loggionisti non saranno probabilmente soddisfatti poiché, a causa della loro progettazione, le due grandi alzate che costituiscono i palchi di primo e secondo ordine impediscono la visione reciproca con la platea. I curiosi non potranno dunque sbirciare socialite e mise delle dame fiorentine.
Il programma è quello classico delle inaugurazioni dove, si sa, la scelta è di norma ormai ristretta al classico Beethoven e a Mahler (Seconda Sinfonia), e qui si è prediletto il primo. Dopo i discorsi di rito, con un divertente fuori programma (Renzi ha consegnato la fascia da sindaco a Mehta per fargli tagliare il nastro), quel che conta è che l’orchestra qui si senta a casa: e lo si capisce fin dalla prima nota che risuona, dell’ouverture beethoveniana cosiddetta Leonore terza. Il risultato è un’ottimale coesione di tutte le sezioni e un bel suono. All’ouverture è accostato un brano, in prima esecuzione assoluta, commissionato dallo stesso Teatro del Maggio Musicale Fiorentino al poliedrico compositore fiorentino Sylvano Bussotti, intitolata Gegenliebe. L’espressione beethoveniana, ripresa dal lied Seufzer eines Ungeliebten und Gegenliebe sta qui a significare, come scrive lo stesso Bussotti, l’anelito a un sentimento corrisposto. E Gegenliebe è concepito come dialogo fra sonorità moderne e musica del passato, a cominciare dall’organico, un’orchestra di proporzioni beethoveniane, cui è aggiunta una nutrita sezione di percussioni, oltre al pianoforte in posizione centrale. Le citazioni musicali che affiorano (come quella del tema del Minuetto del Settimino op. 20), sono dunque rifusi e ripensati in un contesto musicale che fa ampio ricorso a sonorità ben distinte come il frullato dei fiati, il suono della celesta, o la presenza costante delle percussioni, ma sempre leggera.
Nella Nona Sinfonia, cast vocale di primo piano Iréne Theorin, Stella Grigorian, Michael Schade e Albert Dohmen, ottime voci, tra cui si distingue per chiarezza la Theorin. E’ stata una sinfonia equilibrata, di limpida chiarezza, anche se avremmo desiderato, specie nell’attacco dell’ultimo tempo, un po’ più di brio. Buona la prova del coro guidato da Piero Monti. Anche il parterre di vip, defezioni a parte, anche e inspiegabilmente a metà sinfonia, è concentrato, silenzioso; c’era un bel mood, si sente nell’aria.
Apparso originariamente su Sipario