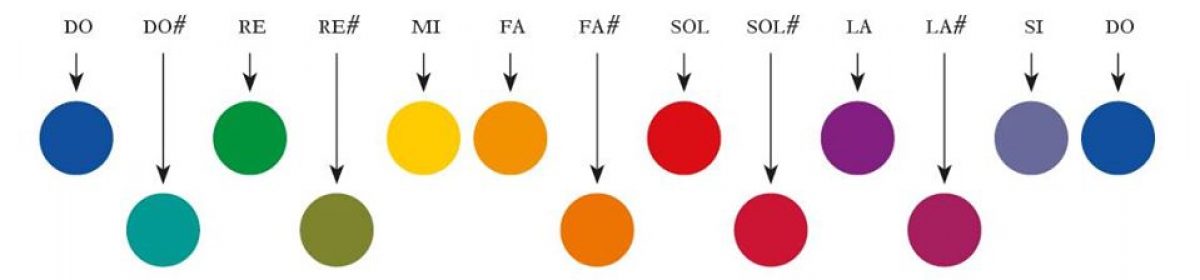Salgari e il melodramma. Gli echi dell’Opera nell’opera di Salgari
Il Cubo editore, Roma 2011, pp. 119, € 14
Tra i tanti testi pubblicati in onore del centenario della morte di Emilio Salgari, quello dell’amica Simonetta Petruzzi Satragni è uno studio originale e informatissimo su uno degli aspetti forse meno noti del romanziere naturalizzato torinese. Salgari e il melodramma, affronta l’attività di critico musicale – «in realtà poco più che un cronista, dotato comunque di buon orecchio» – che Salgari intraprese ventunenne scrivendo prima per «La Nuova Arena» e in seguito per «L’Arena», giornali della natìa Verona. Con franchezza Satragni Petruzzi afferma che è impossibile sapere con certezza «quali fossero le conoscenze del Nostro in campo operistico qualora si prescinda dalle opere cui assisteva per motivi di lavoro nei teatri veronesi».
Non sono tanto i contenuti della critica musicale a interessare il lettore, quanto i paralleli tracciati con sicurezza dall’autrice tra ciò che Salgari ascoltò a teatro e quanto dal palcoscenico confluì, trasformato e riadattato, in più o meno celebri romanzi. Libretti alla mano, sono per esempio accostati l’Attila di Giuseppe Verdi e La tigre della Malesia. La favorita del Mahdi, primo romanzo uscito in volume nel 1887, è il case study: viene tracciata infatti una complessa e ampia rete di corrispondenze (poiché le reminiscenze librettistiche non sempre appartengono a spettacoli recensiti da Salgari), i cui nessi principali si rintracciano nel libretto del grand-opéra L’africana di Eugène Scribe, musicata da Meyerbeer (1865), e ne La creola di Gaetano Coronaro (1878). Anche l’ulteriore capitolo dedicato alle Risonanze librettistiche che appaiono e scompaiono è basato su una conoscenza enciclopedica della librettistica dell’epoca, ma non da meno è l’acribia riservata alla letteratura: per convincersene si legga il capitolo su La bohème italiana. Il “reagente” di questo romanzo «anomalo» stampato nel 1909 è come ovvioLa bohème pucciniana, ma meno prevedibilmente s’innesta nel discorso La piccola bohème operetta semisconosciuta del maestro viareggino Icilio Sadun, andata in scena il 30 marzo 1898. È infine vagliata l’ipotesi che Salgari sia stato un attento lettore di Luigi Illica (celebre librettista, in coppia con Giacosa, di Puccini e, da solo, di Alfredo Catalani), in un’autentica caccia all’indizio che ha per oggetto Siberia messa in musica da Umberto Giordano.
C’è anche il presente: in una rassegna completa non poteva mancare il balletto intitolato a Salgari, musicato da Ludovico Einaudi, con la coreografia di Daniel Ezralow e i testi scelti da Andrea De Carlo, andato in scena a Verona nel 1995, interpretato come una sorta di risarcimento postumo della féerie su soggetto salgariano e con i protagonisti dei suoi maggiori romanzi, che sulle scene non giunse mai.
Originariamente per “24letture” de Il Sole 24ore.com