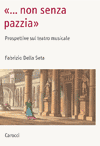 Fabrizio Della Seta, «Non senza pazzia», prospettive sul teatro musicale
Fabrizio Della Seta, «Non senza pazzia», prospettive sul teatro musicale
Roma, Carocci 2008, pp. 320, € 29,50.
Fabrizio Della Seta, cattedratico di Filologia musicale nella Facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia (sede di Cremona), condirettore dell’Edizione critica delle opere di Vincenzo Bellini (Ricordi), ha dato alle stampe per i tipi dell’editore Carocci una raccolta di saggi apparsi in precedenza in atti di convegni, programmi di sala, riviste o come parti di volumi (a volte ancora non disponibili in traduzione italiana). Il nucleo generatore di questa produzione scientifica, eterogenea quanto alla propria origine, è la riflessione su cosa sia definibile “drammatico” e quale sia la sua funzione nell’opera in musica. In questo campo di studi si sono alternate concezioni di tipo prevalentemente letterario o musicale e, in seguito, quelle che hanno individuato come punto di partenza la componente visiva dello spettacolo operistico. Ciascuna di queste concezioni ha fornito risultati importanti alla letteratura musicologica, i quali però non sono stati integrati in una visione globale del fenomeno, in assenza di un concetto di “drammatico” unanimemente riconosciuto dagli studiosi. La categoria di “drammatico”, essendo dedotta dal teatro letterario, ha la tendenza al logocentrismo e questo, nonostante sia funzionale per il teatro letterario, è generatore di equivoci se applicato all’opera.
A ciò si aggiunga un problema che potremmo chiamare “di lungo corso” (indagato nel settimo capitolo, Difficoltà della storiografia dell’opera italiana): la tradizione musicale austro-tedesca ottocentesca che condizionò le sorti della nascente musicologia e che, insieme alla predominanza della drammaturgia wagneriana, contribuì a relegare in una zona d’ombra l’opera italiana; è quindi da tener presente che solo da circa un trentennio questo fenomeno artistico è stimato degno di attenzione senza riserve.
L’argomentazione centrale di Della Seta è che l’opera debba essere compresa precipuamente come fatto drammatico, la cui struttura non necessariamente è determinata dalla parola. La metodologia proposta è di volta in volta messa alla prova nel corso della silloge con l’intento dichiarato di superare la predominanza di una sola visione, perché «in teatro e nell’opera concorrono diversi mezzi espressivi e di volta in volta ciascuno di essi può assumere il ruolo prevalente» (p. 82). Ciò non significa che i singoli approcci sono superati, ma che si integrano virtuosamente l’uno con l’altro.
Nel quarto capitolo, ad esempio, l’autore muove dalla segmentazione del testo della settima e ottava scena nel secondo atto de Le nozze di Figaro di Mozart, e, andando oltre il testo, individua in esso episodi drammatici di senso compiuto, nei quali si compie una trasformazione che modifica i rapporti di forza esistenti fra i personaggi. Precedenti commentatori (Kunze, Abert e Dahlhaus) hanno attribuito poca importanza a ciò che fa avanzare l’azione, cioè il «perdono della contessa [che] da libera concessione è diventato forzato patteggiamento» (p. 83). Se non viene illustrato il funzionamento del “motore immobile” (che lo spettatore intuisce dallo svolgersi dei fatti) sfugge, secondo Della Seta, la “sintassi drammatica”. Dopo la comprensione di questo meccanismo, che non si trova nel libretto di Da Ponte e non è mai esplicitato, il musicologo può inoltrarsi in una proficua analisi musicale della successione di scene.
Nel secondo capitolo è invece preso in esame l’intero atto di Carlo Quinto nell’Ernani di Verdi. In questo caso, l’indagine di due piani espressivi, il musicale e il drammatico, è di tipo comparatistico. La scelta del terzo atto dell’opera è motivata con le parole di Gabriele Baldini, anglista e critico letterario (di cui è discussa la ricezione di Abitare la battaglia nel capitolo conclusivo dell’antologia): «[…] l’arco di una struttura perfetta in cui non c’è da aggiungere, da togliere né da sostituire nulla» (p. 32). Il terzo atto è anche il momento di massima collisione delle tensioni dei due atti precedenti, espresso da Verdi attraverso il linguaggio musicale, in particolare per mezzo della componente ritmica e armonico-tonale. Ancora una volta, il perno del meccanismo drammatico non è un’azione o un conflitto visibile, ma un processo di evoluzione interiore di Carlo, causa dei rivolgimenti che si svolgono in scena. L’atto è diviso in tre strutture; il centro tonale della prima è La bemolle, della seconda Fa, della terza Si. L’esempio presentato, in cui la struttura musicale chiarisce quella drammatica, è il Finale: nel momento del perdono il canto di Carlo compie un percorso tonale che l’orecchio ha imparato a riconoscere nel corso dell’atto e approda alla risoluzione attesa, in Fa minore. Lo stato d’animo di Carlo si estrinseca dunque nella musica e più precisamente nell’andirivieni che la melodia compie partendo da Fa minore (a cui torna sempre), toccando Do minore, La bemolle maggiore e Re bemolle maggiore, configurandosi come «un vero e proprio diagramma armonico del suo contrasto interiore» (p. 45). Allo stesso modo la trasformazione della tonalità di Do in dominante nella seconda scena («S’ora chiamato sono») è un luogo musicale in cui «Verdi rappresenta quasi visivamente l’elevarsi dell’animo di Carlo verso una sfera più alta» (p. 41). Entrambi i casi presi in esame dimostrano come il compositore sia un vero e proprio drammaturgo che si esprime attraverso la musica, alla quale non viene attribuito soltanto il potere di rivestire di suoni azioni e sentimenti già presenti nel libretto, ma quello, ben più importante, di modellare i meccanismi dello sviluppo dell’azione drammatica.
Nel quinto capitolo materia di riflessione è la marcia in tempo 6/8 (menzionata come «musica villereccia, la quale avanzandosi a poco a poco annuncia l’arrivo del Re») che nella scena nona nel primo atto del Macbeth di Verdi accompagna l’entrata di Re Duncano, un unicum (perché non si trova in nessun’altra opera di compositori italiani) e un topos codificato di probabile derivazione francese, la cui origine è da rintracciarsi nella canzone e danza popolari, ripresa dall’opéra- comique, e diffusa dalle canzoni dell’epoca rivoluzionaria. Il significato drammatico dell’uso di questa marcia è ricondotto a una pagina dei Mémoires di André Grétry, prima enunciazione del concetto di “contrasto” in musica, che analogamente mette in scena un re condotto al patibolo.
S’è vista, circa i lavori della prima parte fin qui esemplati, la diversa ampiezza degli oggetti di studio: una successione di scene ne Le nozze di Figaro, un atto in Ernani, una sezione musicalmente compiuta in Macbeth. Nei capitoli restanti Della Seta sottopone ad analisi attenta l’immensamente grande, vale a dire un’intera opera (de La sonnambula è definito il nucleo generatore del conflitto drammatico, mentre Aida è considerata dall’angolatura dell’esotismo), e l’immensamente piccolo, le componenti di una melodia («D’amor sull’ali rosee») di cui è analizzata la struttura melodica (Il trovatore).
I dodici saggi relativi, concepiti negli ultimi venti anni, sono ripartiti in due sezioni: teoria e analisi, storia e critica. In questa seconda parte, oltre ai capitoli citati inerenti la storiografia dell’opera italiana (che si può idealmente riallacciare al dibattito inerente il tema La musicologia europea oggi: quale identità? «Saggiatore musicale», XIII, 2006, pp. 307-48) e la “critica della critica”, a proposito di Abitare la battaglia di Baldini, l’Autore mette a fuoco alcune questioni storiche: la disamina della ricezione ottocentesca di Meyerbeer aiuta a comprendere in che modo il compositore, famosissimo per tutto il corso dell’Ottocento, sia uscito di scena alla fine del secolo, indaga poi l’origine della critica verdiana, focalizzandosi da un lato sulla figura di Alberto Mazzuccato nel decimo capitolo, tratteggiando nell’undicesimo i confini del lessico verdiano attraverso la verifica di suo elemento: la “parola scenica”.
Anche se, come Della Seta annota nell’Introduzione, «le opere che esamino […] ci costringono a prendere una posizione» (p. 19), lungi dall’essere assertivo, egli propone il suo punto di vista aprendosi alla valutazione di chi lo leggerà. Ciò che conta è che il testo rende conscio il lettore, il quale può così entrare nella fucina creativa del musicologo, di una metodologia, che potrà poi vagliare. L’Autore annovera tra le sue stelle polari Harry Powers e Julian Budden (alla cui memoria il libro è dedicato); ancor più presenti in filigrana sono i contributi alla storia dell’opera di Carl Dahlhaus, sempre discussi criticamente.
Uno sguardo alla genesi dell’accostamento critico all’opera di Della Seta è contemporaneamente sintesi di trent’anni di storia recente della cultura (punti di riferimento “classici” di un’epoca come Cassirer, Spitzer, Auerbach, Contini), con un orientamento definito da lui stesso “illuminista”: «impegno a costruire il senso delle cose che si offrono alla nostra coscienza; consapevole della provvisorietà di tale costruzione» (p. 19). L’indovinatissimo motto cui si rifà il titolo deriva dal Prologo in teatro del Faust di Goethe, nel momento in cui il Direttore s’interroga su quale sia la formula di uno spettacolo teatrale ben riuscito, e il Comico ribatte: «ragione, intelletto, sentimento, passione, però − attenzione! − non senza pazzia!». Completano l’opera un ricchissimo apparato di note e una scelta e aggiornata bibliografia. Eccellente veste editoriale e ottima curatela.
Estetica, Genova, Il Melangolo, 02/2008, pp. 127-9
 Ludwig van Beethoven, Epistolario, vol. VI (1825-1827)
Ludwig van Beethoven, Epistolario, vol. VI (1825-1827)
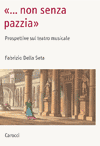
 Le Sonate per pianoforte di Beethoven
Le Sonate per pianoforte di Beethoven
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.